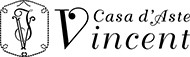Mancini Antonio (Roma 1852 -1930)
Ritratto del pittore Trussardi Volpi
olio su tela, cm 60x100
a tergo cartigli: Mostra A. Mancini, Accademia Tadini, Lovere 1997 n. 19; Mostra del Novecento,Galleria Vincent, Napoli 2010 n. 58
PROVENIENZA : Coll. Privata, Milano; Art Consulting, Modena; Coll. Privata, Napoli
ESPOSIZIONI: Antonio Mancini (1852-1930). Il collezionismo del suo tempo in Lombardia, Lovere,Accademia Tadini, 17 Maggio - 31 Agosto 1997; ART CONSULTING. Raccolta di dipinti e sculture dell'Ottocento e del primo Novecento, Modena, Palazzo Cremonini, 18 Maggio - 18 Giugno 2006; Novecento, Napoli, Galleria Vincent, 24 Aprile - 8Maggio 2010.
BIBLIOGRAFIA: Antonio Mancini. Il collezionismo del suo tempo in Lombardia, catalogo della mostra a cura di S.Rebora, Lovere, 1997; Raccolta di dipinti esculture dell'Ottocento e del primo Novecento, ART CONSULTING, Modena, 2006, Vol. IV, pp. 44-45; OTTOCENTO Catalogo dell'arte Italiana dell'Ottocento , Ed. Metamorfosi Milano 2009, tav. a colori; Novecento, catalogo della mostra, Edizioni Vincent, Napoli, 2010, pp. 78-79; D. Di Giacomo, Antonio Mancini: la luce e il colore, Ianieri Editore, Pescara, 2015, tav. LXIX, p. 115
Romano di nascita, Antonio Mancini visse la sua infanzia a Narni, città d’origine del padre, per poi trasferirsi adolescente a Napoli, forse proprio per ricevere una adeguata educazione nelle arti (nel 1865, anno del suo arrivo in città, risulta già iscritto al Real Istituto di Belle Arti) cui s’era avvicinato fin dalla più tenera età.
Già prima dell’avviamento agli studi accademici tuttavia il giovane Antonio conobbe Vincenzo Gemito (mentre agli anni di formazione risalgono le amicizie con Michetti e Gaetano Esposito), col quale si instaurò un lungo sodalizio che durerà nel tempo; proprio a questa frequentazione ed a quella dello studio del grande Stanislao Lista fu dovuta la prima poetica manciniana, rivolta non solo alla rappresentazione del reale ma più nello specifico a quella del mondo popolano partenopeo: rafforzato sul piano formale dagli insegnamenti di Domenico Morelli, Antonio partorì infatti il suo primo capolavoro, Terzo comandamento (Fremiti di desiderio), prima e molto ammirata opera di una lunga serie dedicata agli scugnizzi ed alla loro infelice esistenza (in perfetta linea con la produzione coeva gemitiana), miseria poeticamente sublimata tuttavia e priva pertanto di una reale intenzione di denuncia sociale.
Ai rapporti amicali si affiancarono ben presto quelli mecenatizi, non inferiori numericamente e anzi assai numerosi, che determinarono di fatto la fortuna di Mancini per tutta la sua vita. Il primo di essi fu con i Cahen, che aprirono all’artista le porte dei Salon parigini senza che egli fosse tuttavia costretto a recarsi in prima persona nella Ville lumière.
Una prima sosta nella capitale francese avvenne effettivamente solo dieci anni dopo il trasferimento a Napoli e su insistente invito di Adolphe Goupil, il celeberrimo mercante che Antonio conobbe quando gravitava nella cerchia del pittore Mariano Fortuny (a Portici nel 1874); Parigi fu nuovamente meta nel 1877 di un secondo viaggio, quest’ultimo però dagli esiti quasi tragici, funestato dai debiti e dalla rottura con l’amico di sempre Gemito.
Di ritorno a Napoli i disturbi psichici di Mancini, a lungo covati, esplosero costringendolo al ricovero in manicomio fino al 1882, periodo in cui non cessò affatto l’attività artistica, che anzi s’arricchì di numerosi ritratti ed autoritratti (vera e proprio costante nella produzione dell’autore). Nel corso dell’anno successivo il pittore si trasferì definitivamente nella natia Roma, dove entrò in contatto con il marchese Giorgio Capranica del Grillo nonché con le famiglie Sargent e Curtis, che attraverso alterne vicende lo condussero fino a Londra: quest’ultima sosta fu foriera ancora una volta di importanti contatti tanto artistici che mecenatizi (da ricordare quello con Mary Hunter, di cui fu eseguito un celebre ritratto).
Facendo a lungo spola tra Inghilterra ed Italia Mancini tornò definitivamente in patria solo dal 1908: cominciò allora un periodo lavorativo prima sotto il mercante Otto Messinger, poi sotto l’industriale francese Fernand du Chêne de
Vère; cominciò tuttavia anche un frenetico susseguirsi di riconoscimenti ufficiali e tributi espositivi: la personale a Venezia nel 1920, l’esposizione alla galleria milanese Pesaro del ‘27, la grande retrospettiva all’Augusteo di Roma dello
stesso anno. Già accademico di San Luca dal 1913, inoltre, Mancini fece anche in tempo ad essere accolto nel ’29 nella nascente Reale Accademia d’Italia, giusto un anno prima della sua scomparsa.
All’arco del primo decennio del XX secolo deve risalire l’opera proposta, secondo una datazione basabile innanzitutto sulla biografia del soggetto ritratto, il pittore Trussardi Volpi appunto, attestato a Roma e proprio tra i frequentatori
dello studio di Mancini nei primi anni del Novecento, come dimostra anche un’altra e forse più celebre tela manciniana coeva che pure raffigura l’artista bergamasco (in una posa poi assai simile). Anche sul piano dello stile risulta del resto
rafforzata quest’ipotesi: con la guarigione dal disturbo mentale che aveva chiuso il periodo napoletano, infatti, termina anche quel citato ciclo di opere dalla vivida connotazione sentimentale e anzi patetica, a favore di rappresentazioni in
tutti i sensi più colorite, segno di una riconquistata distensione spirituale; le figure umane si fanno più voluminose, pesanti, si può dire scultoree, a rivaleggiare poi in questo caso specifico con le statue vere e proprie che circondano il protagonista dell’opera (l’affollarsi di oggetti accessori è a dire il vero una costante nei quadri del Mancini) e che come lui emergono dalla superficie del medium “come rilievi cartografici di catene montuose” (meravigliosa
espressione adoperata da un critico del tempo). L’accumulazione di materia pittorica serviva in effetti all’autore come alternativa al più tradizionale uso delle mezze tinte per una resa più realistica dei giochi chiaroscurali che dovevano
animare le rappresentazioni, e l’effetto ottico risultante finisce così davvero per superare finanche le apprezzate sintesi impressionistiche, riuscendo a coniugare alla visione d’insieme una chiara e precisa definizione analitica delle singole
parti della composizione.