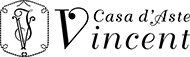De Gregorio Marco (Resina, NA 1829 - 1876)
Fumatori arabi
Olio su tela, cm 17x29
Firmato in basso a sinistra M. De Gregorio Portici
Sul retro: cartellino lacero di antica Galleria di Manchester; doppio timbro ad inchiostro della Galleria “L’Ottocento”, Napoli
Provenienza: Coll. privata, Manchester; Christie’s, Londra; Galleria Vittoria Colonna, Ischia; Galleria L’Ottocento di Russo, Napoli; Coll. privata, Napoli.
Esposizioni: Londra, 1991; Ischia, 1991; Napoli, 1991; Napoli, 2011
Bibliografia: Catalogo Christie’s, Londra 15.02.1991; Dipinti napoletani del XIX secolo, Catalogo Galleria L’Ottocento, Napoli novembre 1991, tav.7; F.C. Greco – M. Picone Petrusa – I. Valente, La pittura napoletana dell’Ottocento, Napoli 1993, tav. 128; Arte moderna e Contemporanea. Dipinti del XIX e XX secolo, Galleria Vincent, Catalogo d’Asta n.32, Napoli 12/03/2011, lotto n.269 p.182-183; Ottocento. Catalogo dell’Arte italiana Ottocento – primo Novecento, n.40, Milano 2011, p. 211; G.L. Marini, Il valore dei dipinti dell’Ottocento e del primo Novecento, ed. XXIX, Torino 2011/2012, p. 271; R. Caputo, La Scuola di Resina nell’Ottocento napoletano, Napoli 2013, tav.78, p.73; P. Belaeff, Marco De Gregorio, Napoli 2014, tav. 92, p. 99; R. Caputo, La Pittura napoletana del II Ottocento, Di Mauro Editore, Sorrento (NA) 2017, p.157.
Marco De Gregorio si trasferì in Egitto nel 1869 e tornò tre anni dopo nel 1871, dopo aver rifiutato la generosa offerta del viceré di rimanere lì come direttore della scenografia del teatro del Cairo di cui aveva dipinto il sipario. Dal Cairo inviò opere di soggetto orientalista alle Promotrici e al suo ritorno portò un discreto numero di schizzi, appunti e fotografie che alimentarono un filone della sua produzione che andava incontro al gusto del tempo. La conoscenza diretta del mondo arabo non si traduceva per lui solo in una ricerca di motivi esotici allora di moda in Europa, ma piuttosto costituiva la conferma delle sue precedenti scelte nella direzione dell’indagine luministica. Ciò che ha colpito maggiormente i pittori che si sono recati nel vicino Oriente è stata la luce zenitale che rende limpidi i contorni delle cose, conferendo loro una notevole evidenza. De Gregorio fece tesoro di tale esperienza e l’utilizzò per approfondire i suoi interessi verso una prospettiva costruita mediante la luce, come si può vedere proprio in questo dipinto. Le figure in penombra in primo piano risaltano con grande evidenza plastica, grazie al contrasto con il secondo piano in piena luce della parete di fondo che riprende alcuni spunti figurativi e compositivi ispirati anche alla poetica dei Macchiaioli, a lui già nota attraverso la frequentazione con Adriano Cecioni.
In particolare, questa nostra piccola, preziosa tela è quella segnalata da Mariantonietta Picone Petrusa nella scheda di un’analoga versione di maggiori dimensioni al Museo di Capodimonte di Napoli (Napoli 1997-98, p.533), la quale fissa la datazione entro il 1874 quando già risulta presente a Capodimonte, ed identificata come Arabi che fumano, presentata alla Promotrice di Genova del 1873. I Fumatori arabi è, dunque, una piccola tela, dipinta fra il 1871 e il ’74 che diviene un tassello prezioso per la ricostruzione della visione orientalista della pittura italiana del XIX secolo. Tant’è che anche Giuseppe De Nittis, sulla scia di De Gregorio, si era interessato a questo soggetto, come dimostra il piccolo olio su tavola con Figura di arabo che fuma (Capolavori dell’Ottocento Italiano nella raccolta Marzotto, Catalogo della mostra di Vicenza 1994, pp. 174-175) un bozzetto che sembra eseguito, con pennellate brevi e intensamente espressive, sull’osservazione diretta del dipinto di De Gregorio, trasformando la figura a sinistra in una macchia scura in controluce.